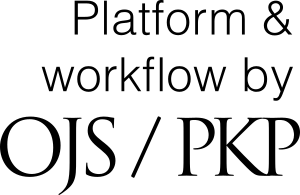CfP 2025: Una vita agile? Il lavoro senza ufficio
Nonostante i tentativi di ripristino normalizzante di uno status quo ante, una volta subiti i colpi pandemici del virus Covid-19 in due, consecutive riprese, l’ufficio – ufficio quale luogo fisico entro le cui mura svolgere un’attività lavorativa (beninteso: un’attività lavorativa intellettuale) – non è più tornato uguale a prima. Legati al tempo della città industriale e incorporati nello spazio di un’organizzazione sociale rotante intorno agli indotti di una fabbrica onnicomprensiva, ai servizi del terziario e del welfare novecentesco, quei palazzi e quei locali pieni di impiegati dediti a mansioni affini e coordinate in una rigida gabbia oraria di ingressi e di uscite, a sua volta coordinata con altre gabbie di altri orari dettati dalla vita urbana della grande città così come della città di provincia, quei locali si sono ritrovati – per un periodo di due anni che è sembrato infinito – vuoti: vuoti di persone.
Privati di esseri umani, gli uffici hanno interrotto la loro foucaultiana funzione vitale, ovvero quella di racchiudere in una stessa sede una massa di uomini e donne e sottoporle alle regole e al controllo di un’azienda che, come ogni istituzione totale, impone un regime chiuso e regolamentato, si impadronisce di parte del tempo e degli interessi vitali dei propri dipendenti, li ingloba al proprio interno in cambio di una contropartita[1]. Quelle stanze sature di personal computer e stampanti, telefoni e fax, fascicoli e raccoglitori, quelle scrivanie disordinate e invase dalla carta, quegli open space illuminati dalle luci al neon bianche e divisi da paraventi plastificati, quei corridoi con la moquette sono la fotografia[2] perdurante, almeno fino agli anni Dieci del XXI secolo, della routine produttiva di una collettività globale fondata sul lavoro, nonché testimonianza spaziale della burocratizzazione di un’alienazione individuale che trova il suo nobile antenato (e antagonista – un antagonista passivo) nello scrivano Bartleby[3] e discendenti più popolari (e crossmedialmente parodistici) nel ragionier Fantozzi[4] e nel manager Michael Scott e gli impiegati della Dunder Mifflin[5].
E al tempo stesso, sotto lo sguardo attento dell’etnometodologo, del sociologo delle organizzazioni e del semiologo, quegli spazi umanizzati hanno perso la loro funzione originaria di organizzatori delle interazioni fra attori per il tramite dei mezzi materiali (alcuni dei quali, tuttavia, già in procinto di “smaterializzarsi” a seguito della digitalizzazione): delle cose, cioè – strumenti, artefatti, arredi – destinate a svolgere la funzione di mediatori che consentiva al “corpo sociale” di auto-realizzarsi in quanto corpo mediante uno «scambio di proprietà fra attori umani e non-umani», per usare le parole di Bruno Latour[6].
Anche per questo, nei lockdown che hanno sospeso la vita degli abitanti della Terra, gli uffici si sono ritrovati non solo svuotati di persone; si sono scoperti – forse per la prima, vera, comprovata volta – privi di (un) senso: del senso conferito alle pratiche dagli spazi fisici – e dagli oggetti – tramite i quali veniva a crearsi una rete relazionale di attori, ma non di quell’altro senso, inscritto nel lavoro-come pratica, destinato a riemergere in un altrove de-situato e de-materializzato. Perché, sebbene senza lavoratori, il lavoro degli uffici nel mondo non si è fermato: abilitato da dispositivi hardware e applicazioni software disponibili da almeno quindici anni, potenziato da infrastrutture di rete sempre più diffuse, stabili e affidabili, lo smart working, che il legislatore italiano intervenuto a codificare una materia imposta come urgente da una prassi di emergenza ha tradotto come “lavoro agile”, ha dimostrato la superfluità di un posto, materialmente individuato nello spazio, all’interno del quale convocare dalle nove della mattina alle cinque del pomeriggio, per cinque giorni alla settimana, colleghe e colleghi.
Oltre a preannunciare il tramonto del fordismo da ufficio in favore dell’alba di una “scrivania diffusa”[7], all’effetto dirompente del lavoro agile sullo spazio corrisponde, come è inevitabile, un secondo effetto dirompente, che riguarda la riconfigurazione del tempo del lavoro. Se è vero che i meccanismi tecnici di regolamentazione e controllo dell’ufficio fisico sono replicabili con agio e anzi maggiore penetrazione pervasiva dall’ufficio smart, è altrettanto indiscutibile che la sottrazione alla presenza fisica in sede libera ore preziose idealmente da rivalorizzare per la famiglia, il divertimento e il riposo. Il Pietro Paladini di Caos Calmo, che trasferisce il suo ufficio in una panchina in un parco sotto la scuola della figlia per starle vicino in un momento delicato, ne è un prototipo letterario recente[8]. Ma la sua è una scelta tutta personale, dettata da un trauma (la morte della moglie) e soprattutto favorita dalla sua posizione apicale (è un dirigente ai vertici dell’azienda per la quale lavora), mentre gli smart workers di oggi appaiono parte di una riprogettazione complessiva del modello lavorativo che coinvolge l’organizzazione burocratica, la definizione di tutti gli inquadramenti delle professionalità e la qualità stessa della vita lavorativa[9]. Se negli anni Duemila il lavoro ha raccontato, nella sua forma precaria e nel quadro della globalizzazione occidentale, «l’orizzonte esistenziale di una generazione»[10] (si pensi, tra gli altri, ai romanzi di Bajani, Nove, Murgia, De Marchi in Italia), resta da indagare quanto la Generazione Z, nelle proprie aspirazioni di inserimento lavorativo, o le generazioni precedenti già occupate e/o precarizzate, diano per scontato, se non addirittura benefico, questo ulteriore processo sistemico e in che modo la letteratura, il cinema e le altre arti stiano dando rappresentazione, e interpretazione, di questa transizione verso lo smart working e un’ipotetica smart life. Se un tavolo in un bar o un tavolo della cucina convergono in un “posto fisso”, come non chiedersi se ci troviamo di fronte a una subdola espropriazione capitalistica della sfera privata, sottomessa a un dominio che rende l’abitazione stessa un “non-luogo” nei termini descritti da Marc Augé: un punto di transito come un altro tra il login e il logout dalla rete aziendale, rispetto al quale il desiderio della stabilità e del controllo della libertà personale di movimento alimenta soltanto una nostalgia di regimi spaziali e temporali idealizzati – una nostalgia utile a dissimulare un apparato digitalmente convergente di potere e di controllo[11].
Il dossier monografico del numero 29-2025 di «Testo e Senso» chiama a una riflessione aggiornata, anche attraverso un confronto con la narrazione del Novecento, sul racconto di un lavoro concepibile come smart, smaterializzato e de-territorializzato, un lavoro in cui l’assenza, o meglio l’estensione dei limiti fisici dell’ufficio genera un terreno ambiguo e problematico di “vita agile” all’interno della quale dimensione professionale e dimensione personale entrano in rotta di collisione. Come sempre, comparatistica e teoria della letteratura, critica letteraria, studi culturali, semiotica, intermedialità, linguistica, antropologia, scienze cognitive sono i campi privilegiati per il confronto interdisciplinare che la rivista promuove.
Le proposte di contributo per il dossier, così come per le altre sezioni fisse della rivista (Altra critica, Digital Humanities, Medicina narrativa e Neuronarratologia, Paragone delle arti, Studi di genere), devono essere inviate alla Redazione entro il 31 agosto 2025, seguendo le linee guida redazionali e la procedura pubblicate su questo sito.
Il numero 29-2025 sarà pubblicato nel mese di dicembre.
---
[1] Erving Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, trad. it. di F. Basaglia, Torino, Einaudi, 2003.
[2] Lars Tunbjörk, Office / LA Office, Londra, Loose Joints, 2024.
[3] Herman Melville, Bartleby lo scrivano [1853], trad. it. di Gianni Celati, Milano, Feltrinelli, 1991.
[4] Paolo Villaggio, Fantozzi, Milano, Rizzoli, 1971.
[5] The Office (NBC, 2005-2013).
[6] Bruno Latour, Una sociologia senza oggetto? Problemi di interoggettività [1994], trad. it. in La società degli oggetti, a cura di Eric Landowski e Gianfranco Marrone, Roma, Meltemi, 2002, p. 227.
[7] Massimiliano Panarari, Dopo la stagione delle scrivanie è il momento della “gerarchia piatta”, «La Stampa», 24 giugno 2023, <https://www.lastampa.it/specchio/temi/2023/06/25/news/dopo_la_stagione_delle_scrivanie_e_il_momento_della_gerarchia_piatta-12873769/> (Consultato: 31 gennaio 2025).
[8] Sandro Veronesi, Caos calmo, Milano, Bompiani, 2005.
[9] Federico Butera, Dal lavoro agile alla new way of working, in Studi e saggi, a cura di Giovanni Mari et al., Firenze, Firenze University Press, 2024.
[10] Carlo Tirinanzi De Medici, Il romanzo italiano contemporaneo. Dalla fine degli anni Settanta ad oggi, Roma, Carocci, 2018, p. 220. Ma cfr. anche Silvia Contarini, Raccontare l’azienda, il precariato, l’economia globalizzata. Modi, temi, figure, «Narrativa», nn. 31-32, pp. 7-24.
[11] Grafton Tanner, Nostalgoritmo. Politica della nostalgia, trad. di it. Marco Carassai, Roma, Tlon, 2024, pp. 65-75.